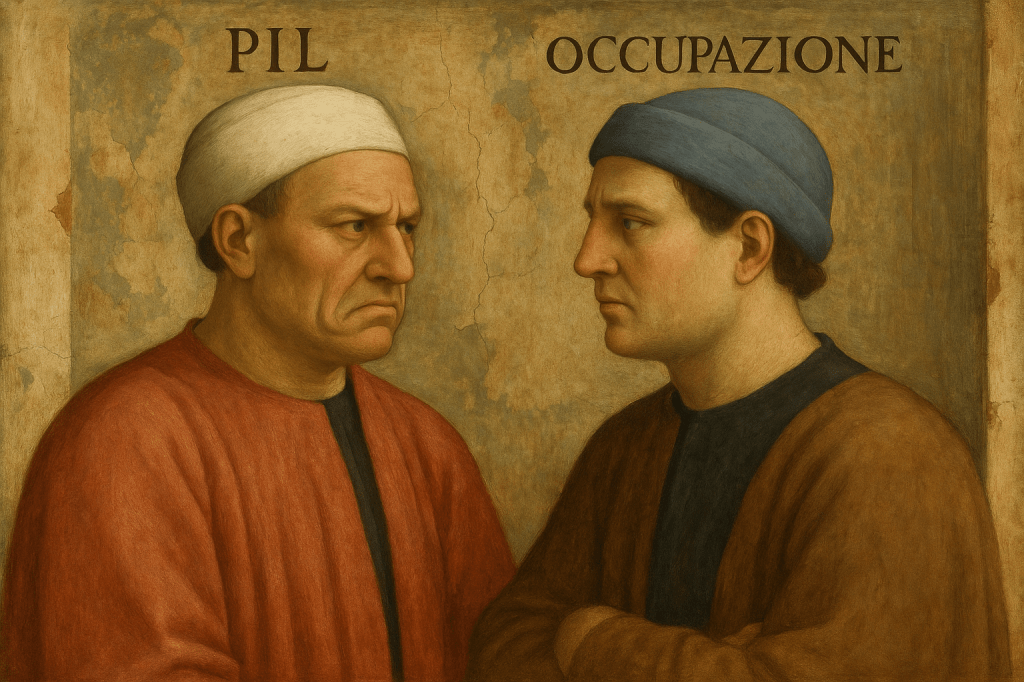Hai letto l’articolo “il mismatch…”?
I numeri, presi da soli, sembrano una buona notizia. Secondo gli ultimi dati Istat aggiornati a ottobre, gli occupati in Italia hanno toccato un massimo storico: circa 24,2 milioni di persone, con un tasso di occupazione al 62,7%, una disoccupazione intorno al 6% e un tasso di inattività al 33,2%, tra i più alti d’Europa. Nello stesso tempo, però, la stessa Istat prevede per l’economia italiana una crescita del Pil intorno allo 0,5% quest’anno e poco sopra lo 0,7–0,8% nel 2026. Il linguaggio è quello consueto: crescita “zero virgola”. Da qui la domanda, inevitabile: com’è possibile avere più persone al lavoro, senza avere più ricchezza prodotta? Perché lavoro e Pil, che per anni venivano presentati come grandezze che camminano insieme, oggi sembrano correre su binari diversi? Per provare a capirlo bisogna entrare un po’ sotto la superficie dei numeri.
Più occupati, ma che tipo di lavoro?
Il primo passaggio è semplice da dire ma decisivo da capire: non tutta l’occupazione pesa allo stesso modo sul Pil. Negli ultimi anni il numero degli occupati è aumentato, ma una parte importante di questi nuovi posti di lavoro è concentrata in attività a basso valore aggiunto. Sono lavori che richiedono competenze limitate o poco aggiornate, spesso svolti da persone con scolarità modesta o con formazione non coerente con i bisogni produttivi delle imprese. L’Ufficio parlamentare di bilancio ha osservato che, nel periodo post-pandemia, l’aumento dell’occupazione è stato trainato soprattutto da persone che sono passate dall’inattività al lavoro: persone che non lavoravano e non cercavano lavoro e che entrano nel mercato per la prima volta o dopo lunghi periodi di assenza. In molti casi non portano con sé un mestiere già “rodato”, ma devono iniziare da zero, con tutte le fragilità in termini di efficienza, autonomia, capacità di generare valore. È un’occupazione che conta ai fini statistici, ma che fatica a trasformarsi in produttività e in Pil.
Il segnale che arriva dalle imprese: meno ingressi, più prudenza
Il quadro si completa con altri dati. Le imprese, per il trimestre dicembre–febbraio, programmano ancora circa 1,3 milioni di assunzioni, ma segnalano una frenata: a dicembre gli ingressi previsti calano di quasi il 6% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, con un arretramento più marcato nella manifattura, nel commercio e in agricoltura. L’industria, in particolare, prevede meno assunzioni rispetto allo scorso anno, e questo è un campanello d’allarme perché proprio lì si concentrano molti lavori ad alto contenuto professionale, quelli che di solito trainano anche la produttività. Solo le costruzioni tengono, sospinte ancora dagli effetti del PNRR e dei grandi cantieri. Nel terziario le imprese continuano ad assumere, ma soprattutto in turismo, ristorazione e servizi alla persona: settori dove la stagionalità è forte, le retribuzioni sono spesso basse e la rotazione del personale è continua. Anche le forme contrattuali dicono qualcosa: la maggioranza delle entrate previste a dicembre è ancora a tempo determinato, sopra la metà del totale, mentre i rapporti a tempo indeterminato restano poco più di un quinto. È vero che negli ultimi anni ci sono state molte trasformazioni da contratto a termine a contratto stabile, ma il cuore del sistema continua a reggersi su una base ampia di rapporti temporanei o comunque fragili. In questo contesto, le imprese dichiarano di avere difficoltà a trovare circa il 46% delle figure richieste. In alcuni comparti tecnici e operai specializzati si arriva a quote ben superiori al 60%. Significa che quasi un posto su due è “difficile da coprire”: non mancano solo i lavoratori, mancano i profili giusti. È il sintomo di un paese che da un lato crea occupazione, dall’altro non riesce a costruire e incrociare le competenze necessarie per far crescere davvero la produzione.
Salari bassi, potere d’acquisto eroso
C’è poi il capitolo salari. L’UPB ricorda che, rispetto al 2020, i salari reali medi in Italia sono ancora intorno al 9% in meno. Non è tanto una caduta delle buste paga lorde, quanto l’effetto dell’inflazione che ha mangiato potere d’acquisto più in fretta di quanto i contratti siano riusciti a recuperare. Dopo la pandemia e con la crisi energetica, le imprese hanno dovuto fronteggiare costi più alti per energia e materie prime. Una delle principali valvole di sicurezza è stata la moderazione salariale: si è continuato ad assumere, ma spesso a condizioni economiche molto contenute. Il risultato è paradossale: ci sono più persone che lavorano, ma molte di loro restano in una condizione di fragilità economica. Nasce così la figura, sempre meno rara, del “povero che lavora”. Questo pesa anche sul Pil. Se milioni di lavoratori hanno stipendi che bastano a malapena per le spese essenziali, la domanda interna di beni e servizi resta fiacca. I consumi non decollano e, senza consumi, la crescita complessiva del paese rimane tiepida.
La produttività e il valore del mestiere
A questo punto entra in gioco un concetto chiave: la produttività. In termini semplici, è il rapporto fra ciò che produciamo e le risorse che utilizziamo per produrlo, tempo di lavoro compreso. Un lavoratore è davvero produttivo quando conosce bene il proprio mestiere, ha accumulato esperienza, sa usare gli strumenti tecnici, è inserito in un’organizzazione che funziona. Tutto questo richiede tempo, formazione iniziale e continua, percorsi di crescita, investimenti aziendali. Se un sistema economico si basa invece su mansioni povere, poca formazione, alto turnover, contratti brevi e scarsa possibilità di specializzazione, allora genera molti posti di lavoro “leggeri”: utili a gonfiare il numero degli occupati, ma incapaci di innalzare il livello medio di produttività del paese. E qui si collega il discorso sul mismatch che ho trattato in un articolo a parte. È difficile far crescere la produttività quando le imprese non trovano le figure tecniche e specializzate di cui avrebbero bisogno, mentre molti lavoratori si ritrovano in attività di ripiego non coerenti con le proprie capacità. L’incontro fra domanda e offerta di lavoro, in queste condizioni, avviene spesso in modo casuale, non progettato. Risultato: il lavoro c’è, ma è lavoro che vale poco, perché non si appoggia su mestieri robusti, competenze aggiornate e percorsi di crescita.
Perché aumentano gli over 50
Un altro elemento che colpisce nei dati Istat è la composizione per età dell’occupazione. Su base annua la crescita è trainata quasi esclusivamente dagli over 50, mentre diminuiscono le fasce 15–34 e 35–49. Le ragioni sono molteplici. Da un lato pesano l’invecchiamento demografico e le riforme pensionistiche: ci sono più persone fra i 50 e i 64 anni e queste persone restano più a lungo al lavoro. Non è raro, come in molti possiamo aver osservato nella nostra esperienza personale, che qualcuno continui a lavorare anche dopo essere andato in pensione, stipulando nuovi rapporti che ai fini statistici vengono conteggiati come occupazione. Dall’altro lato, in molti comparti si è rallentato il ricambio generazionale. I lavoratori più esperti vengono trattenuti perché conoscono l’azienda, i processi, i clienti; i giovani faticano a entrare in numero adeguato, oppure entrano con contratti intermittenti e percorsi poco chiari. È un assetto che da un lato mantiene in circolazione competenze preziose, dall’altro rischia di ridurre la capacità del sistema di innovarsi. Una struttura produttiva che invecchia e un Pil che cresce poco si rinforzano a vicenda: si investe meno, si assume con prudenza, la mobilità sociale rallenta.
Il tempo diverso di Pil e occupazione
C’è infine un elemento più tecnico ma importante: in economia il mercato del lavoro reagisce con ritardo rispetto all’andamento della produzione. Quando il Pil rallenta, le imprese non licenziano subito. Cercano di resistere, riducono gli straordinari, rinviano gli investimenti, tagliano le spese non essenziali, ma tendono a conservare il capitale umano già formato, nella speranza che la situazione migliori. Per qualche trimestre si può quindi avere una combinazione strana: Pil quasi fermo o in calo e occupazione che ancora tiene, o addirittura cresce di poco. Se la frenata si prolunga, inevitabilmente anche i numeri del lavoro iniziano a peggiorare. È possibile che l’Italia si trovi in questa “zona grigia”: i dati più recenti registrano ancora livelli occupazionali elevati, mentre le previsioni sul Pil sono modeste e gli stessi bollettini sulle assunzioni programmate segnalano prudenza, specialmente nella manifattura. In altre parole, l’onda lunga del rallentamento economico non ha ancora colpito in pieno il mercato del lavoro, ma i segnali di raffreddamento iniziano a vedersi.
Che giudizio dare di questo quadro?
Mettendo insieme tutti i tasselli, l’immagine che emerge è quella di un’Italia che ha fatto un passo avanti nella quantità di occupazione, ma non ancora nella qualità del lavoro e nella capacità di crescita. Da un lato è certamente meglio avere più persone al lavoro che meno. Ridurre disoccupazione e inattività resta un obiettivo fondamentale, anche sul piano umano e sociale. Dall’altro lato, però, non ci si può accontentare dello slogan “mai così tanti occupati”. Se l’occupazione aggiuntiva è concentrata in lavori a bassa produttività, con salari reali fermi o in calo, con scarsa possibilità di apprendere un mestiere solido, il rischio è quello di costruire una nuova forma di precarietà: occupati numericamente, ma economicamente fragili. Il nodo politico e civile sta tutto qui. Non si tratta solo di contare quanti lavorano, ma di chiedersi che tipo di lavoro viene offerto, quale dignità garantisce, quale futuro apre, quale contributo porta alla crescita complessiva del paese. Solo mettendo insieme questi piani – quantità di occupazione, qualità dei contratti, livello dei salari, formazione, mismatch fra domanda e offerta – i numeri dell’Istat smettono di essere una sfilata di percentuali e diventano una fotografia critica del modello di sviluppo in cui viviamo. È da lì che dovrebbe ripartire il dibattito pubblico: non dalla propaganda sul “record di occupati”, ma da una domanda semplice e scomoda. Che Italia raccontano davvero questi dati? E che Italia vogliamo costruire, per i giovani di oggi e per gli over cinquanta che ancora tengono in piedi interi pezzi del sistema produttivo?